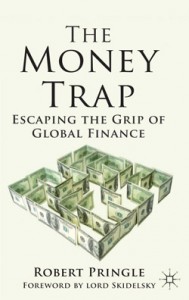 Un nuovo standard monetario?
Un nuovo standard monetario?
Della crisi finanziaria internazionale iniziata nel 2007 con il fallimento dell’inglese Northern Rock, ma esacerbata nell’anno successivo col rifiuto delle autorità americane di salvare la Lehman Brothers, sono state fornite dalla letteratura economica e dalla pubblicistica parecchie spiegazioni. Squilibri macroeconomici strutturali, politiche economiche troppo lasche, legislazioni agevolanti la Ponzi finance[1], “fallimenti del mercato”, commistione di attività bancarie commerciali e di investimento, inadeguatezze del “regolatore”, debolezze del governo societario, sono stati indicati, con diversa enfasi, in alternativa o congiuntamente, come “chiavi di lettura” della crisi. Il recente, ambizioso libro di Pringle[2], tuttavia, sposta l’attenzione verso un fattore rimasto in ombra nelle trattazioni dell’argomento: l’assenza di uno standard globale nel sistema finanziario. Come nota Skidelsky nella prefazione, il libro connette la discussione del sistema monetario con la crisi del sistema bancario: due temi in genere trattati da diversi gruppi di esperti (p. XV). L’autore intende spiegare in quale senso si possa parlare di deficienza di uno standard, e poi ricollegare ad essa l’origine e la “intrattabilità” della crisi finanziaria. Prospetta infine, sia pure in modo tentativo e – secondo la sua stessa ammissione – non compiutamente definito, quale forma questo nuovo standard debba assumere, e quale struttura bancaria sia funzionale a tale standard.
Va subito osservato che il libro prende le distanze da ogni prospettiva di efficienza implicita nel funzionamento dei mercati finanziari, mentre assume il public good come obiettivo che il sistema monetario e finanziario deve proporsi. Tuttavia, l’autore è lungi dall’identificare il perseguimento del “pubblico bene” con un forte ruolo della mano pubblica. Secondo Pringle, questo “pubblico bene” fu, in passato, incorporato in sistemi basati su cambi stabili (dapprima sullo standard aureo e poi sulle istituzioni di Bretton Woods). Sul piano storico, l’autore è propenso (con Bordo e, potremmo aggiungere, con la Schwartz) ad accreditare la tesi secondo cui il collasso del gold standard sia stato dovuto più a un comportamento “asimmetrico” dei paesi in surplus (S.U., Francia, che non avrebbero perseguito politiche espansive adeguate al loro stock aureo), che a difetti strutturali del sistema. Nel quarto di secolo successivo alla seconda guerra mondiale e agli accordi di Bretton Woods, la stabilità monetaria ha trovato il suo fondamento nel sistema di cambi fissi e di indiretto legame con l’oro, attraverso il dollaro. L’inflazione fu contenuta, mentre la provvista delle banche era basata su stabili depositi del pubblico, la concorrenza bancaria era limitata, la stessa self-regulation, laddove presente (come nella City di Londra), era efficace. Nota Pringle che le istituzioni di Bretton Woods – che poi divennero, per i critici di sinistra, un simbolo della conservazione – erano in effetti il risultato di idee socialiste prevalenti in Europa e del New Deal americano. Il gold standard e il sistema di Bretton Woods differiscono perché il primo era un sistema non pianificato, funzionale ai mercati, ampiamente auto-regolato, senza una sovrastruttura istituzionale e senza un palese potere egemone (ma – si potrebbe obiettare – non era tale quello inglese prima del conflitto 1914-18?). Il secondo era pianificato, piuttosto ostile ai mercati, con regole ben convenute e con un’istituzione centrale che ne verificava l’operatività, e con un’evidente potenza egemone, gli S.U. Eppure, entrambi furono in grado di fornire un’ancora monetaria sulla cui base il commercio mondiale e gli investimenti si espansero grandemente, le economie si internazionalizzarono, la finanza crebbe su basi ordinate. Le istituzioni di Bretton Woods assicurarono il massimo di autonomia monetaria nazionale compatibile con la disciplina di un sistema internazionale.
L’autore attribuisce l’abbandono dei cambi fissi e l’instabilità successiva – origine e risultato di una sorta di “non-sistema” – a tre fattori principali, riguardanti la politica monetaria, la crescita dei mercati finanziari e, paradossalmente, il ruolo crescente delle banche centrali.
In particolare, l’accomodamento delle politiche monetarie non sarebbe stato possibile entro le “costrizioni” di un complesso ben definito di regole, esistente nei sistemi precedenti. L’accelerazione dell’inflazione negli S.U., legata alla lunga espansione kennediana e al finanziamento della guerra del Vietnam, indebolì il perno del sistema, il dollaro.
La crescita dei mercati finanziari e l’aumento dei flussi speculativi di capitale permisero agli Stati in difficoltà di finanziamento di svincolarsi dai prestiti ufficiali, così sfuggendo alla disciplina del precedente sistema. L’ascesa della finanza globalizzata rese inefficaci risposte a livello solo nazionale e generò una “relazione incestuosa” tra grandi banche e governi. Gradualmente, la moneta – fiat-money – è stata “detronizzata” dal suo alto ruolo pubblico, istituzionale, è stata assoggettata ai capricci del policy-makers, e inevitabilmente è divenuta terreno di giuoco (playfield) del settore privato; i costi delle crisi dalle banche si sono trasferiti sulla mano pubblica (sul contribuente).
Ma una sorta di standard monetario comunque emerse, attraverso il riconoscimento dell’indipendenza delle banche centrali e l’affidamento di più ampi poteri, con quasi-fiscal responsibilities. Tale loro riposizionamento permise di rimpiazzare la disciplina di regimi precedenti con un “non–sistema” di cambi fluttuanti, funzionale all’interesse delle banche centrali di gestire autonomamente la propria politica. L’introduzione di un regime di cambi variabili trovò così nelle banche centrali un alleato, nel senso che l’indipendenza della loro politica dipese ampiamente da tale regime. Ogni approssimazione a un sistema di cambi stabili, o anche a una più stretto coordinamento delle loro politiche, fu vista come lesiva della capacità di adempiere compiutamente al proprio mandato, da loro interpretato in termini puramente domestici e di obiettivi spesso rigidamente definiti. Il risultato fu, frequentemente, un nazionalismo monetario: “an excercise in monetary unilateralism” (p. 62). Volcker domò l’inflazione negli S.U., ma mise in crisi per un decennio l’America Latina. L’inflation targeting è – nota l’autore – “ in my view a superficial, naive concept” (p. 85): la stabilità dei prezzi al consumo ha catturato solo una frazione di ciò che tradizionalmente si intende per moneta sana, poichè l’innovazione finanziaria ha portato alla creazione di ampie passività e attività quasi-monetarie, non rilevate nelle misurazioni ufficiali dell’offerta di moneta (shadow banking system).
Prima della crisi globale era diffusa la convinzione che, se le banche centrali avessero stabilizzato l’inflazione nel breve termine e se i “regolatori” avessero fatto bene il loro lavoro, il sistema finanziario e l’economia nel suo complesso avrebbero preso cura di se stessi. Dopo la crisi, le banche centrali, che – nota Pringle – erano largamente responsabili di questa visione, hanno avuto successo nell’attribuirne la responsabilità a fattori quali squilibri mondiali (il surplus della Cina e un’insufficiente rivalutazione della sua moneta), una troppo lasca vigilanza bancaria, una cattiva gestione del rischio. Secondo l’autore, alla domanda: “quale bussola seguire in uncharted waters come quelle attuali”, la risposta appropriata è che la moneta stessa dovrebbe essere la bussola; ma per consentile di esserlo, cioè di servire la sua cruciale funzione sociale, una nuova costituzione monetaria internazionale dovrebbe essere adottata.
Secondo Pringle, essa dovrebbe far leva sulle impersonali, decentralizzate forze del mercato e non sullo Stato e dovrebbe includere uno standard non solo monetario, ma anche bancario e finanziario. E’ una “visione”, un’ “utopia” – dice l’autore – che vale la pena di esplorare (pp. 250-253).
Una moneta sana dovrebbe mantenere costante il suo valore in termini reali. Potrebbe essere definita come una frazione minimale del totale delle attività reali dell’economia mondiale, espresse dai titoli che le rappresentano (“equity claims on real assets in the global economy”) (p. 251). Tale frazione sarebbe la nuova unità monetaria (chiamata Ikon, “icona”, rappresentazione). Il suo valore sarebbe legato alla crescita reale dell’economia, come rappresentata dagli equity claims. Pur essendo il suo rendimento nominale pari a zero come in ogni forma di cash, questo suo rendimento reale (return on cash) la renderebbe attraente come store of value, perché risulterebbe ridotta la differenza tra il suo rendimento, legato in sostanza alla crescita dell’economia mondiale, e il rendimento reale di investimenti alternativi. Sembra quindi di intendere che in fase di espansione economica, e quindi di crescita degli equity claims, cresca anche il rendimento reale dell’Ikon, e che di conseguenza debba salire il tasso di interesse di mercato per indurre gli agenti economici ad abbandonare il cash. In tal senso – se il pensiero dell’autore è correttamente interpretato –l’Ikon opererebbe come stabilizzatore automatico.
Tale schema opererebbe attraverso un currency board – che potrebbe essere ad esempio il FMI – il quale cederebbe Ikon alle singole banche centrali che volontariamente aderiscano al sistema, contro valuta nazionale a un tasso fisso di conversione. Queste ultime cederebbero a loro volta l’Ikon al settore privato. Ikon e valute nazionali/regionali (dollaro, euro, sterlina, ecc) coesisterebbero.
Come integrare la discussione sul futuro delle banche e sulle riforme del sistema finanziario, col dibattito sul futuro del sistema monetario, come sopra delineato? L’autore individua la risposta nella conversione degli attivi bancari in investimenti in titoli detenuti da varie forme di fondi d’investimento (mutual funds). Sembra quindi che, secondo Pringle, questi fondi perderebbero la loro ragion d’essere attuale, di forme di diversificazione di un portafoglio, per divenire strumenti di cambiamento strutturale del sistema bancario. Al riguardo, l’autore riprende l’idea – recentemente avanzata da Laurence Kotlikoff (Jimmy Stewart is Dead, Wiley, 2010) – secondo cui la quantità di moneta sarebbe costituita dalla forma più liquida di questi fondi (i cash mutual funds), sui quali soltanto si potrebbero trarre assegni. I detentori di cash mutual funds potrebbero essere quindi assimilati ai depositanti; al di là di tali specifici fondi, i depositi sarebbero sostituiti da forme di partecipazione al rischio degli investimenti: gli assets dei fondi “would be direct investments in the real economy and their liabilities [would become] ‘shares’ where the risks are borne by the investor (depositor)” (p. 278). Gli agenti privati non bancari investirebbero prendendo comunque il rischio delle scelte effettuate: non più depositanti o obbligazionisti ma equity holders. Ogni intermediario non assumerebbe più posizioni in proprio, ma assumerebbe le caratteristiche di un asset manager.
Secondo una variante dello schema, citata da Pringle, che può farsi risalire a Irving Fisher (100% Money, Adelphi, 1936), ma più recentemente riproposta da Robert Litan, l’unica forma possibile di banca sarebbe una narrow bank, ove i depositi sono solo investibili in attività sicure (al limite in conti presso la banca centrale): le banche opererebbero solo come perno del sistema dei pagamenti, il “resto” essendo investimento di rischio (il rapporto Vickers nel R.U., il rapporto Liikanen nell’U.E., la “Volcker rule” negli S.U. [3] non coincidono con il radicalismo di quegli schemi, ma di esso probabilmente risentono).
Sia con i cash mutual funds sia con la narrow bank le autorità riguadagnerebbero il pieno controllo della quantità di moneta, venendo meno ogni effetto moltiplicatore dei depositi bancari. In questo senso – nota Pringle citando James Buchanan – un’anarchia hobbesiana (quale quella generata da un sistema monetario alimentato da forme private di quasi-moneta) lascerebbe posto a una moneta “costituzionalizzata”.
Diversi aspetti, come l’operatività dell’Ikon, sono lasciati dall’autore – volutamente – analiticamente indeterminati. Pringle cerca un appoggio “reale” (backing) al sistema finanziario globale, un appoggio che, nei sistemi da lui citati, era storicamente rappresentato dall’oro e poi da un dollaro convertibile. Ma egli rifiuta ogni ancora valutaria o la scelta di una commodity specifica, vedendo piuttosto tale ancora nel complesso dei titoli rappresentativi della ricchezza mondiale. Curiosamente, il tentativo più vicino, sul piano storico, di un ancoraggio siffatto potrebbe rinvenirsi nella breve esperienza della Rentenbank tedesca del 1923-24: uno strumento che ebbe successo nell’arginare l’inflazione, restituendo fiducia al sistema monetario tedesco. L’ancora fu allora rappresentata da un’ipoteca sulle terre e sulle proprietà industriali, commerciali e bancarie tedesche, basata su cessioni coattive del 4% del loro valore. Coerentemente, il bilancio della Rentenbank portava al proprio attivo tale ipoteca. Nella proposta di Pringle, dovrebbe il currency board acquistare, e mettere al suo attivo, un basket di titoli azionari nel momento in cui crea Ikon? Oppure l’Ikon sarebbe creato su base di un indice rappresentativo dei titoli, ma non attraverso un loro effettivo possesso? Le idee di riforma sono avanzate da Pringle in forme tentativa e aperta al dubbio. L’autore stesso ne sottolinea l’intento fortemente propositivo, ma anche, al momento, utopistico. Se il libro contribuirà a sviluppare un dibattito sulla centralità della moneta in ogni schema di riforma finanziaria, esso avrà raggiunto l’obiettivo che il suo autore si è prefisso.
Note
1. Secondo lo schema disegnato da Hyman Minsky in Stabilizing an Unstable Economy, McGraw Hill, 2008.↑
2. Robert Pringle è fondatore e presidente del giornale Central Banking; è stato primo direttore del Gruppo dei Trenta.↑
